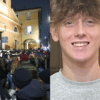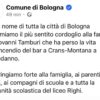Purtroppo, sport intrattenimento politica e violenza hanno da sempre viaggiato su binari destinati ad incrociarsi in alcuni momenti della storia dell’umanità, come dimostra in modo plastico l’affresco rinvenuto a Pompei della zuffa tra pompeiani e nocerini, oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
E per quanto noi ci possiamo ritenere più civili e per quanto i gusti per sport e spettacolo siano fortunatamente cambiati, questo affresco dimostra però che quando si parla di eventi con migliaia di spettatori e forti emozioni, sia in realtà cambiato ben poco.
Quando qualcosa va a colpire i nostri sentimenti, le nostre vite, le nostre tasche e, perchè no, il nostro campanilismo, un evento di puro intrattenimento così come una manifestazione pacifica possono sfociare in atti di violenza.

Affresco della zuffa tra Pompeiani e Nocerini (Wikipedia)
L’affresco della zuffa tra Pompeiani e Nocerini conservato al MANN
Partiamo dall’inizio e intanto inquadriamo l’affresco in qualità di reperto archeologico. Pittura muraria ritrovata a Pompei nel 1869, si trovava nella domus di Actius Anicetus. L’immagine è divenuta talmente iconica da soppiantare il nome del padrone di casa visto che lo stabile è anche noto come “la casa della rissa”.
Conservato oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), questo affresco di quarto stile datato tra il 52 e il 79 dopo Cristo, è uno dei pochi ritrovati che mostra un evento storicamente documentato e quasi certamente il primo che tratti di una rissa avvenuta durante dei giochi gladiatori.
Come spesso accadeva in passato, non si trattò di una mera degenerazione di tifo per una o l’altra fazione, ma questo fu semplicemente la cartina di tornasole per recriminazioni campanilistiche più complesse e che con lo spettacolo, centravano ben poco.
Nell’affresco, è ben visibile e riconoscibile l’anfiteatro di Pompei, ed all’interno si possono vedere i giochi gladiatori. Attorno all’anfiteatro poi, la palestra, altri edifici, giardini e bancarelle dei venditori ambulanti. In ogni punto della zona raffigurata, dagli spalti alle strade, passando sotto gli alberi e in mezzo alle bancarelle, vi sono persone intente a picchiarsi.
Sempre a Pompei, nella cosiddetta Casa dei Dioscuri, è stato ritrovato un graffito con queste parole di censura: «O Campani, siete morti insieme ai Nocerini in quella vittoria». Parole che evidenziano come l’accaduto fosse tristemente ben noto.
L’evento, in effetti, fu qualcosa di proporzioni enormi, con numerosi morti, una quantità indefinita di feriti e parecchie persone che ricevettero amputazioni importanti. Insomma, molto più di una “zuffa”.

Positivo di “Pompeiani e Nocerini” del fotografo Francesco Caso (BeniCulturali.it)
La zuffa tra Pompeiani e Nocerini
Ma cosa avvenne esattamente quel giorno? Fondamentalmente accadde che, durante uno spettacolo di gladiatori, si scatenò una rissa che dilagò per l’intera cittadina campana, tra spettatori locali e venuti da fuori Pompei.
Tacito, nei suoi Annali (libro XIV, 17), ci informa che «A quel tempo una causa futile provocò un atroce massacro tra i coloni di Pompei e di Nocera durante un combattimento gladiatorio offerto da Livineio Regolo […]».
E poi continua descrivendo come iniziò tutto e le conseguenze:
«Dapprima i cittadini a turno s’insolentirono continuamente, poi scagliarono i sassi e infine ricorsero alle armi, prevalendo la gente di Pompei, presso cui si svolgeva lo spettacolo. Pertanto, molti nocerini furono riportati in città col corpo mutilato dalle ferite, e in tanti piangevano la morte dei figli o dei genitori. L’indagine delle cause fu affidata da Nerone al Senato, che la rinviò ai Consoli. Riferita la relazione ai senatori, furono vietate ufficialmente queste riunioni per dieci anni e le associazioni, che avevano operato contro la legge, furono sciolte; Livineio e gli altri autori della sedizione furono condannati all’esilio».

L’anfiteatro di Pompei (Wikipedia)
Campanilismo e politica, le vere motivazioni
Il “futile motivo” citato da Tacito come pretesto per la rissa, in realtà non è del tutto futile. Non si parla solamente di “discriminazione territoriale”, come li si definirebbe oggi allo stadio, o insulti dovuti a un tifo differente. La motivazione è in realtà politico/sociale.
Nuceria Alfaterna (il nome di Nocera all’epoca) era diventata una colonia romana, crescendo di conseguenza di importanza e ricevendo nuovi terreni agricoli, tolti proprio alla cittadina di Pompei.
Ecco, quindi, che durante questi giochi gladiatori, gli apprezzamenti e gli insulti sullo spettacolo sono stati semplicemente un pretesto. E dalle parole, si è passati alle mani e poi alle armi. E il tema non era certamente più il favore per un gladiatore o l’altro. Era un tema economico e sociale riferito ai terreni e al loro sfruttamento.
La rissa di Pompei: pene dure, ma non durature
Inizialmente la pena fu durissima. Come si legge dalle parole di Tacito: esilio per coloro i quali avevano fomentato la folla e che si erano resi protagonisti degli scontri, e cessazione degli spettacoli per 10 anni.
Ma sebbene fosse lontana da venire la nostra Repubblica, eravamo pur sempre in Italia, e le pene furono dure ma non così tanto, e la giustizia fu uguale per tutti, ma per alcuni lo fu di più. Gli scontri avvennero nel 59 d.C. e già nel 62 d.C, l’impianto di Pompei era nuovamente in attività. E alcuni degli esiliati, tornarono in città. Da dieci anni a meno di tre: una bella differenza.
Il terremoto e la “Realpolitik”
Ma perché la pena venne ridotta? Chiaramente, le motivazioni sono sempre politiche, e sono probabilmente almeno un paio.
Una potrebbe essere proprio per via della città di Pompei. La rissa scoppiò durante il regno di Nerone, nella città natale di Poppea Sabina, in quel momento moglie dell’Imperatore (a cui è attribuita la meravigliosa villa di Oplontis). Così come accadrebbe oggi, quindi, si può ipotizzare che Poppea si spese per il proprio territorio, facendo pressioni per diminuire la pena. Sia per la cittadinanza che per gli amici cha dai giochi traevano profitto e influenze. Una cosa che accadrebbe anche oggi.
La seconda motivazione invece è di ordine pubblico, e di realpolitick ante litteram. Nel 62 d.C. a Pompei ci fu un violento terremoto che danneggiò pesantemente l’intera città. Il sito archeologico di Pompei mostra ancora parecchie testimonianze di quel forte sisma. Il modo migliore per mantenere tranquilla la cittadina era sicuramente quello di riaprire l’anfiteatro e indire de giochi.
L’anfiteatro venne quindi restaurato e riaperto, in modo che la popolazione pompeiana potesse svagarsi ed allentare le tensioni dovute e possibili problemi legati al post-sisma, oltre che diminuire la pressione sulle autorità locali. D’altra parte, ricordate la locuzione di Giovenale “panem et circenses”?